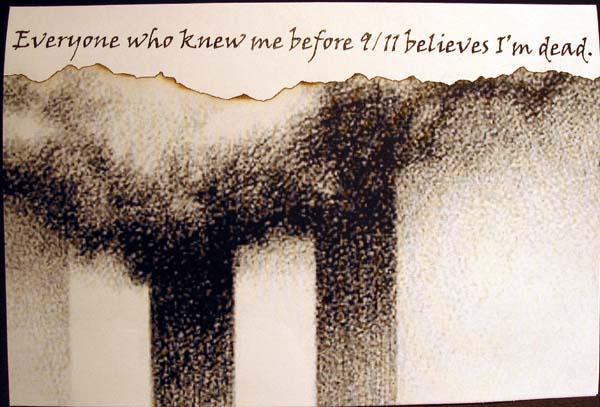Quando ho detto che avrei voluto essere il tuo cane vagabondo

Tanto per cominciare una stazione e una scritta sul muro. Quella scritta è più sottile di quanto sembri, cangiante. Forse davvero rimanda a una canzone dei Diaframma, forse è soltanto il patetico inno di chi unisce le ammaccature sentimentali al triste fenomeno dell’essere punkabbestia, piaga mai troppo stigmatizzata. Ha un segno finale di chiusura (una parentesi?) ma non si vede da dove parta tutto ciò. Poi io passo lì davanti mentre vado a comprarmi il panino salame piccante e provola per il viaggio. Io decontestualizzo tutto quello che mi capita davanti, persino la mia ombra è un’ombra cinese. Jens Lekman nelle sue canzoni cita mezzi di trasporto, tram, taxi e la luce. Il cane vagabondo è una coincidenza tra un regionale e un eurostar.

Reduci dal party di laurea “Santo Subito!”, nel segno del cane broccolone ci siamo spostati verso il Covo con un’impazienza tale che davanti alla porta chiusa c’era soltanto il nostro gruppo e pochi altri noti. Imbambolato davanti alle proiezioni sulle pareti valuto la carenza della sezione beveraggi del posto. L’apertura della serata è affidata a tale
Jenny Wilson e, sarà per la sua presenza matronale, sarà per gli atteggiamenti, sarà per la sua musica, ma non sembra per niente una mia coetanea. Imbraccia una chitarra con pericoloso fare da folk-singer e non ha nessuno intorno a sé. Sullo sfondo un ragazzino spolvera il mixer con un pennello da mobili. La musica della Wilson è quel paio di dozzinali sandali rossi (in questo momento sono molto attratto dall’uso della parola dozzinale, scuserete): non scaccia l’immagine di una cantautrice infognata nel suo essere brutta copia di brutte copie, disco di sconosciuto epigono venduto al mercatino dell’usato tra i suoi imbarazzanti sandali, il vestito che non riesco a definire nemmeno panda e le pantofole simil-DeFonseca del dopo concerto. Per quanto lanci dall’aggeggio posto sullo sgabello basi pseudotroniche e friccichii assortiti, l’impressione è che questi elementi non si mischino con la ripetizione stanca di formule e non provino nemmeno a salvare il salvabile per quanto siano avulsi dalla scrittura dei pezzi. Come se non bastasse, la sua voce non è particolarmente interessante (dozzinale?). Ci si chiede dove l’abbia raccattata Jens Lekman o chi per lui, se sia un’amica o una confidente a cui deve troppi favori e soprattutto ci si chiede se in un percorso di implosione progressiva questa Jenny Wilson spingerà qualche giovane donna sui sentieri della fastidiosa epigonia. Ma mentre ero assillato da simili paure, Jens Lekman, le Spice Psychogirls e il violinista preso in prestito da un set porno svedese anni settanta erano già sul palco.

La prima a salire sul palco è la violoncellista, bruna mole vichinga, collare per cani e calze a righe su collant: sistema il suo strumento e posiziona il portatile dall’impresentabile sfondo desktop con cui farà partire le basi quando necessario. La violoncellista manterrà per tutto il concerto espressioni di musica altezzosità oscillanti tra il rapimento mistico e l’orgasmo semitonico, punteggiati qui e là da qualche sorriso a denti stretti. La violoncellista è sempre immersa in una luce
rossa. Gli altri arrivano tutti insieme. La band di Jens Lekman è composta quasi esclusivamente di ragazze, ognuna caratterizzata rispetto alle altre per un’inezia, un particolare. Oltre alla violoncellista circondata dal rosso, l’immagine classica della posh tastierista e della tamburina bionda è stata sovrastata dalle tre espressioni contate dell’
incantevole bassista (sguardo sbarrato verso sua sinistra, sguardo sbarrato a occhi chiusi, sguardo sbarrato con sorriso). Il violinista dall’aspetto vagamente rattuso, si occupa anche delll’ormai immancabile
campanaccio e si unisce ai cori dal microfono posto sotto le corde dello strumento, seguito nell’azione dalla violoncellista circondata dal rosso. Jens Lekman ha una maglietta bianca dal collo vissuto la cui illustrazione rimanda ai Decemberists e ai loro velieri. Alterna una chitarra e un ukulele di romantico fiore ornato. Canta anche lui per quasi tutto il tempo a occhi chiusi, indossa una coppola e porta una mirrorball come portachiavi.
La maggiore curiosità con cui mi apprestavo al concerto riguardava come sarebbe stato reso il trasporto grandorchestrale di alcuni pezzi. Il numero di persone sul palco non ha certo evitato l’uso di basi e campionamenti. Pur nondimeno le canzoni non sono state imballate in scatole e in andamenti precotti, un po’ per le variazioni di tempo rispetto agli originali (quasi tutte al rialzo) e un po’ per la capacità di fornire un insieme caldo e non meccanico. Paradossalmente questo risultato non è stato raggiunto grazie a particolari capacità dei musicisti: la tamburina spesso rimpolpava sezioni ritmiche già presenti su base, l’incantevole bassista non aveva grossi compiti e, scuserete, ma non ho decifrato bene il compitino della posh tastierista. Più incisivo il lavoro della sezione archi sia dal lato melodico che da quello legante. Gran merito va allora alla prova senza sbavature di Lekman e al suo alternare pieni e sottili vocali, alla scrittura di queste canzoni che evita l’effetto karaoke proprio perché ammette fin dall’origine, quando Lekman non rimane solo con il suo ukulele, una preregistrata certezza di sostegno.
Certo il concerto è stato breve, pur essendo costituito da quasi tutto
When I Said… (ma mancava la canzone del compleanno e dei testimoni di Geova), da alcune canzoni recuperate dagli EP (ma mancava un saluto di/a
Rocky Dennis) e da versioni recuperate dal dipartimento delle canzoni dimenticate (ma mancava
Boisa-bis-o-boisa, che sarà anche una cacatina ma non resisto al campionamento simil-Royksopp-remixano-KoC + (s)citazioni nel testo assurdo + nonsense bambinesco). Certo Lekman non si è diretto verso il prato esterno per soddisfare le richieste più disparate come aveva promesso e si è limitato a un mini-show per pochi nel camerino. Certo potrei trovare altri tre, massimo due, difetti a una sessantina di minuti così piacevoli. Invece restano alcuni frammenti. Restano gli andanti col tamburo grasso, con gli archi che fioriscono primaverili e le parole fraintese a nostro piacimento come in
Maple Leaves o come i tormentoni creati con l’imbecillità del T9. Resta un messaggio non mandato per non svegliare qualcuno su
Do You Remember The Riots? e Jens che grida che vuole vedere quel fuoco, senza stonare. Resta
Pocketful of Money, dove la musica non finisce e cullato dal piano corro insieme a una voce cavernosa e familiare. Resta il violino finale di
Psycho Girl che mi ricorda la canzone di Gianni Morandi sui comandamenti e il papa (primotunonprendiparteneancheaunabarzelletta). Resta il battimani e la dedica ‘ncarcerata di
You Are The Light. Resta qualcuno che lì accanto piange e ride. Resta la delicatezza di uno straniero che conosce le canzoni che conosci tu e da loro non sa scappare. Resta quella ghetto-figata della dolce notte d’estate del 1993, che nomina
Regulate di Warren G e i nostri sedici anni: bom-bo-bom-bo-bom-bo-bom-bo-bom-bo-bom e microfono portato al petto. Resta un jack staccato. Resta un fiore forse di plastica che per uno strano gioco di luci e ombre cinesi disegna un cane vagabondo su una maglietta.